
A proposito della Palestina sotto il mandato britannico, la violenza degli anni Venti e Trenta viene spesso liquidata come una sequenza di “disordini” o “incidenti” tra comunità. Questa lettura attenuante oscura un dato essenziale: già nel primo dopoguerra, la violenza entrò nella vita del territorio e venne normalizzata e sfruttata nella gestione coloniale. L’amministrazione britannica scelse consapevolmente di evitare uno scontro diretto con la leadership araba, perché una presa di posizione chiara avrebbe messo in discussione il proprio dominio e l’assetto imperiale dell’area.
La tensione sociale emerse con forza per la prima volta nel 1920, a Gerusalemme, proprio all’inizio del Mandato. Durante le celebrazioni di Nabi Musa, la violenza anti-ebraica esplose in forma collettiva. L’amministrazione britannica si trovò davanti a un bivio che orientò tutta la sua politica successiva: garantire la protezione delle comunità civili oppure mantenere l’ordine secondo priorità imperiali? Prevalse la seconda opzione. Le forze britanniche intervennero quando la violenza aveva già prodotto morti e devastazioni e gestirono gli eventi come semplice problema di ordine pubblico, evitando qualsiasi riconoscimento della loro natura mirata.
Nel 1921 la violenza si estese a Jaffa e ad altri centri urbani. Gli attacchi colpirono persone, attività economiche, luoghi di lavoro e quartieri in cui lo sviluppo ebraico era più visibile. Questo aspetto rivelò un elemento centrale: la violenza prendeva di mira anche un modello sociale ed economico perché percepito come destabilizzante. L’intervento britannico restò tardivo e privo di incisività; l’amministrazione liquidò gli scontri come tensioni locali e, come se non bastasse, reagì con misure che colpirono proprio le comunità ebraiche: restrizioni all’autodifesa, confisca delle armi, controllo sempre più stretto delle strutture comunitarie.
Il 1929 segnò il punto di non ritorno. A Gerusalemme, Hebron e Safed la violenza assunse la forma del pogrom. A Hebron, in particolare, la comunità ebraica, radicata lì da secoli, venne praticamente spazzata via. L’intervento britannico arrivò solo a massacro compiuto e, ancora una volta, la mattanza venne trattata come una banale rivolta, un escamotage linguistico che permise di eludere ogni responsabilità politica diretta. Le sanzioni contro i rivoltosi restarono marginali e, anzi, semmai il rapporto con la leadership araba si consolidò ulteriormente.
Dal 1936 la violenza assunse carattere continuativo. Per tre anni, fino al 1939, attacchi armati, sabotaggi e intimidazioni di matrice araba colpirono insediamenti ebraici, infrastrutture e interessi britannici. L’amministrazione mantenne la sua posizione: alternò repressione e concessioni. La possibilità per gli ebrei di costruire una difesa autonoma restò sistematicamente ostacolata e la sicurezza venne usata come leva di controllo politico, non come strumento di tutela.
La minaccia al governo coloniale, data dall’accelerazione economica e sociale operata dagli ebrei nella Palestina mandataria, fu la ragione principale di questa politica. Ecco perché si decise di sfruttare la violenza esercitata dalla società araba: doveva disinnescare il cambiamento, per permettere una maggiore controllo sulla regione. La strategia britannica fu, in buona sostanza, un divide et impera. L’innovazione portata dal movimento sionista, foriero di modernizzazione agricola, organizzazione del lavoro, cooperazione, diritti sociali, idee politiche nuove avrebbe finito col demolire la logica coloniale fondata sulla gerarchia, sull’equilibrio con élite tradizionali arabe e sulla conservazione dell’ordine.
Gli ebrei vennero, così, trattati come un problema meramente politico, ancor prima che culturale e demografico.
Con la tolleranza delle violenze e la connivenza con la leadership araba, il conflitto si radicalizzò e si stabilizzò. Le conseguenze di questa politica esercitata dal governo britannico stanno alla base del conflitto che, ancora oggi, funesta l’intera regione.
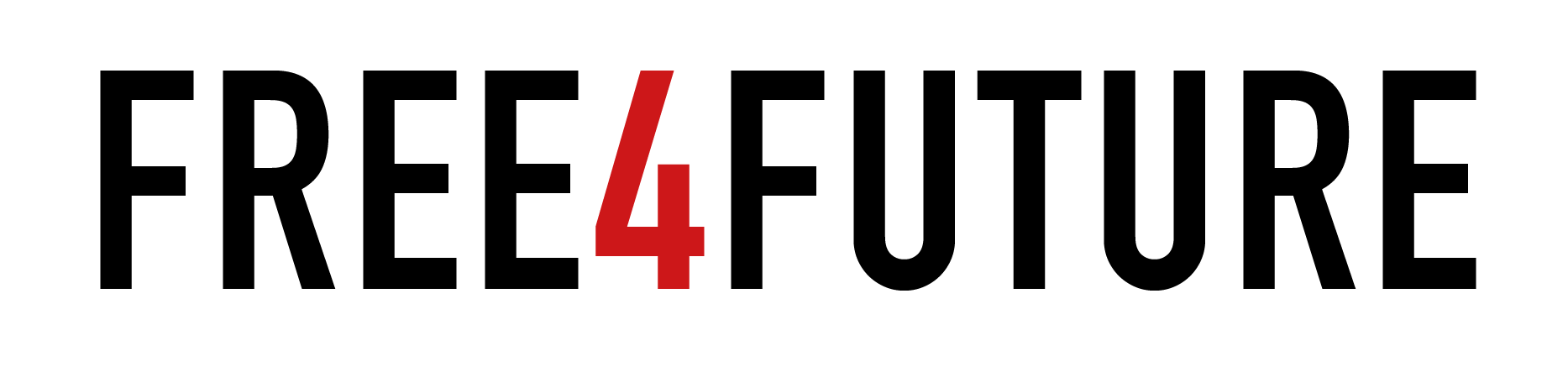





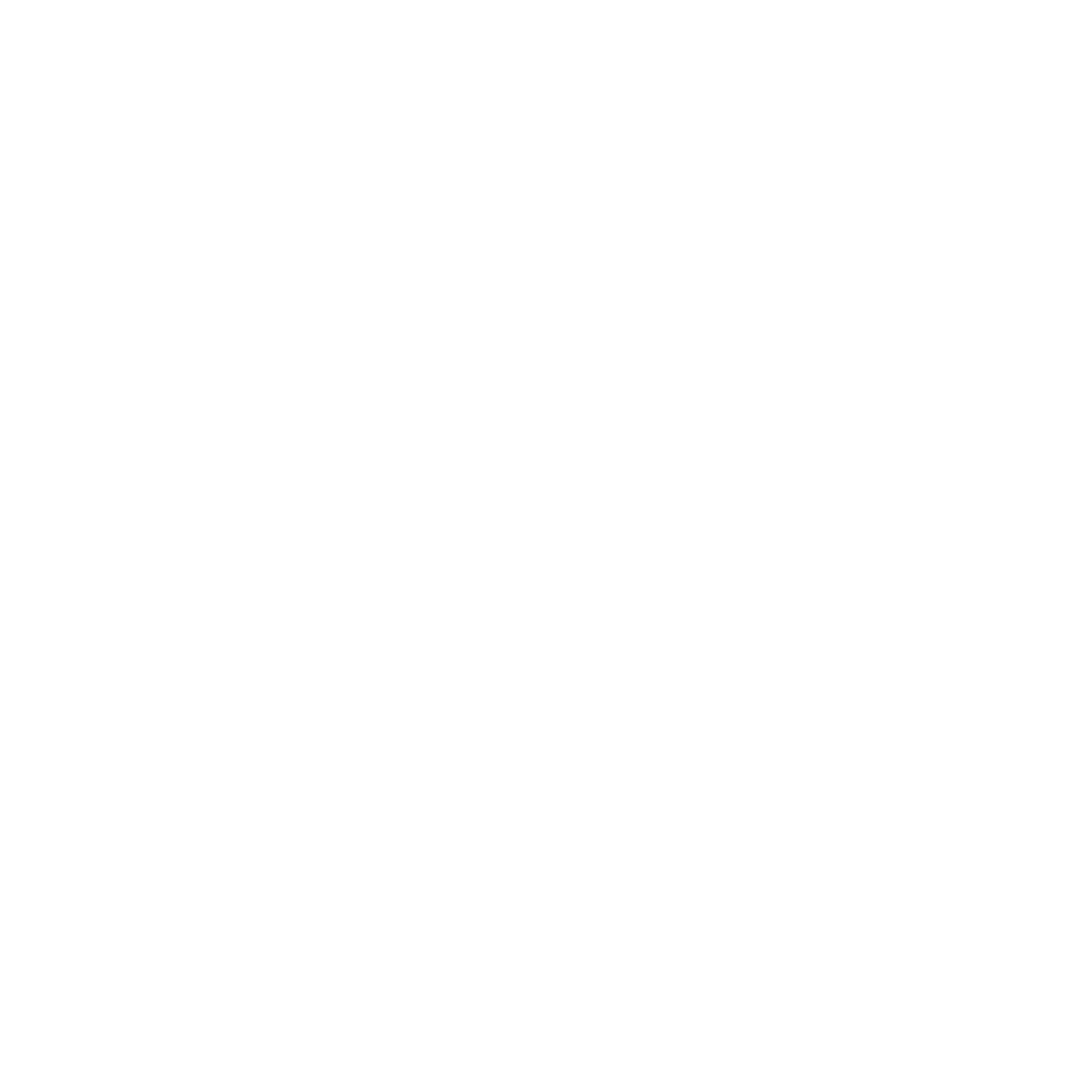
Add comment