16 maggio 2025: Il massacro sdoganato, l’equilibrio del terrore da preservare
C’è un filo rosso che attraversa le pagine dei giornali italiani, sempre più visibile, sempre meno censurato. Un’idea che avanza con disinvoltura tra gli editoriali e i commenti, fino a diventare una condizione: per arrivare alla pace, Israele deve perdere. Non trattare, non vincere con moderazione, ma perdere. Non in astratto, ma in senso simbolico, storico, perfino militare. Perché – secondo questa logica – una vittoria israeliana sarebbe una sconfitta per l’umanità.
“Accettare la sconfitta”: la nuova premessa etica
È Gabriele Segre, dalle colonne della Stampa del 16 maggio, a scriverlo senza eufemismi:
“Accettare una sconfitta parziale è l’unica via per arrivare alla pace”.
Non si tratta di una constatazione geopolitica, ma di un imperativo morale. Israele, per riconciliarsi col mondo, deve perdere. Anche sul piano ideale. Anzi, soprattutto su quello. La tesi è costruita per gradi: Israele ha vinto sul campo – “la liberazione di parte degli ostaggi, l’indebolimento di Hamas, i colpi inferti all’asse iraniano” – ma questa vittoria sarebbe avvelenata da “una perdita simbolica e ideale”, cioè la crisi del progetto sionista e l’isolamento globale. Da qui la proposta: trasformare quella perdita in “consapevolezza”, abbracciarla, farla diventare fondativa. Solo chi perde può essere giusto.
Il massacro come riscatto storico
Nel Manifesto, la stessa logica prende la forma della “giustizia storica”. L’articolo di IainChambers, accostando Gaza al “ritorno dell’archivio coloniale”, propone una lettura della guerra come prosecuzione della decolonizzazione. In questa cornice, non conta più chi bombarda o chi sequestra: conta chi rappresenta la memoria della vittima. E in questo schema, la vittima può colpire senza perdere la sua aureola morale. Israele, invece, per espiare, deve essere ferito, destabilizzato, umiliato.
Il giorno stesso, Eliana Riva scrive sulla stessa testata che “Israele si sta abbattendo su Gaza con una violenza che non lascia scampo”, e denuncia la “costruzione di strutture per la distribuzione selettiva degli aiuti”, leggendo tutto come un piano di “pulizia etnica”. Ma lo fa accanto a un altro messaggio: Gaza come luogo di resistenza storica. Il dolore, se serve al riscatto, diventa arma legittima.
Quando solo uno può perdere
Nessuno chiede a Hamas di accettare la sconfitta. Nessuno invita Hezbollah a “fare i conti con la propria responsabilità storica”. Nessuno scrive che la vera pace comincia dal disarmo morale dell’Iran. Il principio della “sconfitta necessaria” è applicato esclusivamente a Israele.
Anzi, quanto più Hamas sopravvive, quanto più riesce a presentarsi come soggetto politico, tanto più la stampa lo accredita come parte del processo di pace. Persino il titolo de Il Fatto Quotidianolo esplicita: “L’uomo di Donald che tratta con Hamas e sfida Netanyahu”. L’ex emissario americano Adam Boehler viene descritto come il volto di una diplomazia pragmatica che “parla con tutti”, e Hamas è un interlocutore che “non ha le corna” ma “è fatto di uomini”. Netanyahu, invece, è colui che “mina gli sforzi di mediazione”.
Una pace a senso unico
La nuova narrazione ribalta i criteri. La guerra è sbagliata se la fa Israele. La pace è legittima se nasce da un’auto-sconfitta. Il dolore palestinese è politico, quello israeliano è accessorio. Persino la donna incinta uccisa a colpi di arma da fuoco il 14 maggio – caso raccontato con dignità da David Zebuloni su Libero – viene ignorata dal circuito mediatico dominante. In compenso, si legittima il boicottaggio, si appoggiano le mozioni accademiche, si normalizzano cortei in cui si urla “Palestina libera dal fiume al mare”.
Perché nella nuova retorica, la pace non si costruisce sul compromesso, ma sulla punizione. E questa punizione è riservata a una sola parte.
Quando i media parlano il linguaggio di Hamas
Questa convergenza tra commentatori e strategia di Hamas non è accidentale. È strutturale.
La comunicazione di Hamas si fonda da sempre su una vittoria morale nella sconfitta materiale: il martirio come propaganda, la devastazione come prova di resistenza, la sofferenza come moneta di scambio. Ecco perché l’obiettivo non è vincere la guerra, ma fare in modo che Israele non possa vincerla senza perdere legittimità.
Il 16 maggio, questa strategia è stata perfettamente assorbita da parte del sistema mediatico occidentale. Lo si vede nella tesi di Segre (“Israele deve accettare la sconfitta”), nella retorica storicista del Manifesto, nella legittimazione del dialogo con Hamas, nell’assenza sistemica di condanna simmetrica per chi ha fatto del massacro uno strumento identitario.
Così, la linea comunicativa di Hamas trova sponde autorevoli non solo nelle piazze, ma nelle redazioni. E il messaggio passa: Israele può essere accettato solo se ferito, piegato, simbolicamente sconfitto.
Una pace così non è pace. È la prosecuzione della guerra con altri mezzi. E il giornalismo che la sostiene non informa: combatte. Ma dimentica da che parte si è schierato.
E soprattutto, rimuove l’ovvio: che tutto questo è possibile solo perché Israele è l’unico Stato al mondo a cui si chiede di giustificare la propria esistenza ogni giorno. Solo perché l’ebreo, nella storia europea, ha dovuto sempre morire in silenzio per essere considerato umano. E oggi si pretende che lo Stato ebraico faccia lo stesso.
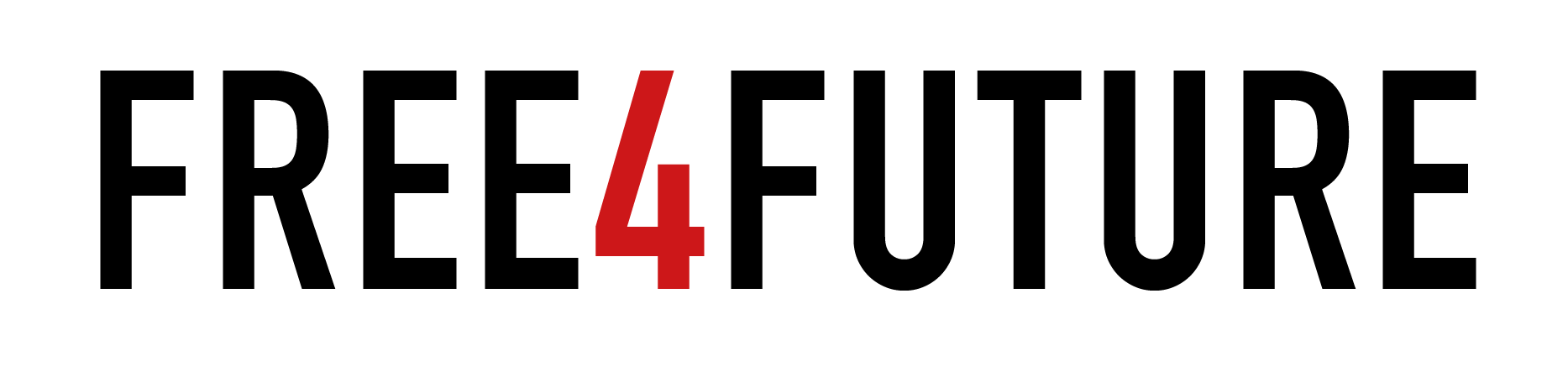





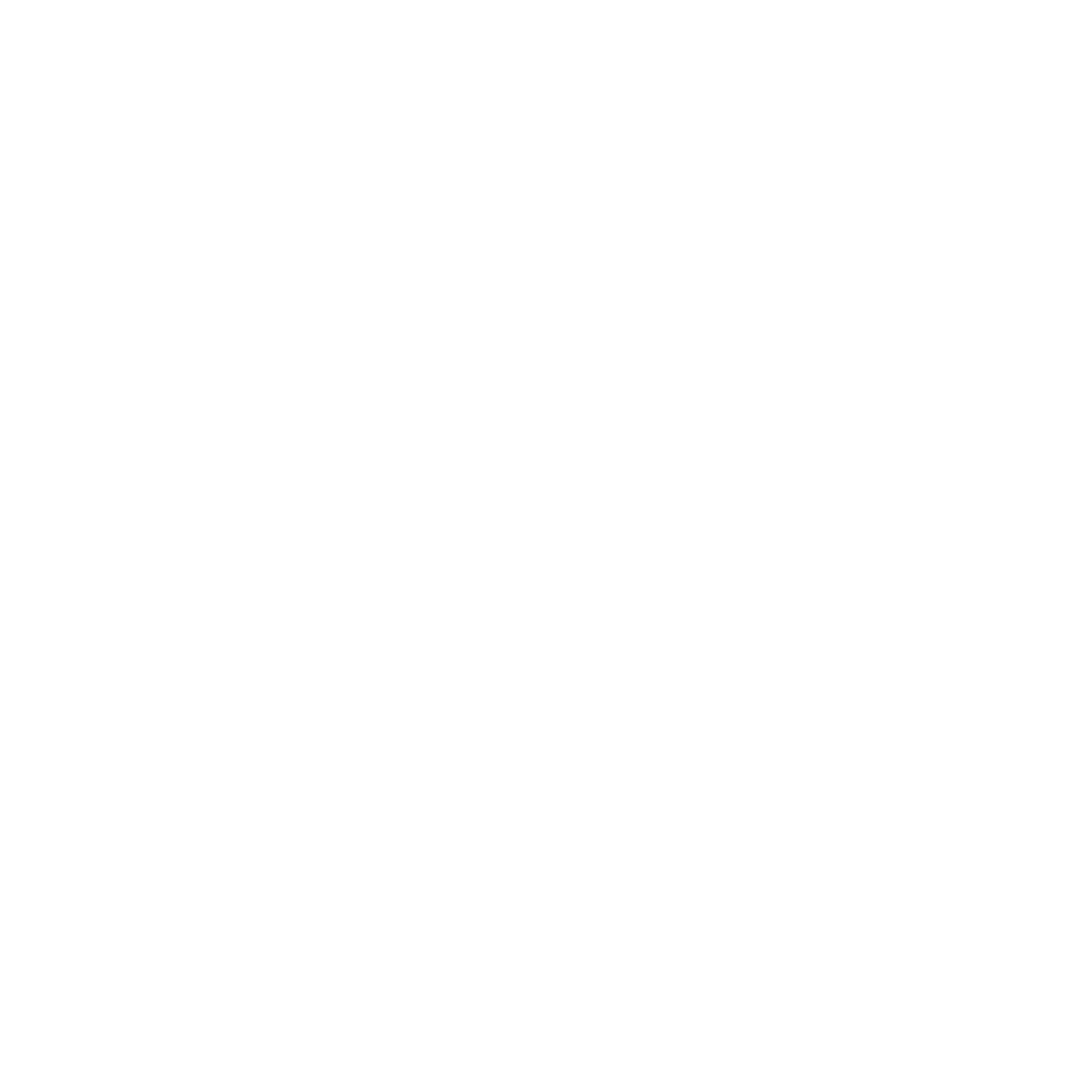
Davvero un lavoro prezioso il vostro.
Complimenti a tutti quelli che se ne occupano.