
Tre articoli, un’unica verità rivelata: Israele è il male, la Palestina è il martirio, e Hamas non esiste.
Così La Stampa del 3 novembre 2025 compone il suo ciclo pittorico sulla guerra, tre pannelli che si incastrano perfettamente: il caso Tomer-Yerushalmi, il campo dei bambini e la condanna di Cacciari.
Un trittico che sembra Giotto, ma è Hamas.
Nel primo articolo, Fabiana Magrì scrive che «la procuratrice generale dell’Idf è stata arrestata per aver diffuso il video degli abusi nel centro di Sde Teiman» e che «Netanyahu parla di uno dei danni più gravi mai subiti dall’immagine di Israele». Il racconto è impostato come una parabola morale: Israele che punisce chi dice la verità.
Ma la verità è più complessa. Il video in questione non era una “denuncia”, ma materiale coperto da segreto militare e già oggetto di inchiesta interna da parte delle stesse autorità israeliane. Il video, inoltre, era pesantemente alterato: tagliato, rimontato e accompagnato da una narrazione che non mostrava realmente ciò che sosteneva di mostrare. Eppure è bastato per alimentare una gigantesca campagna internazionale contro l’IDF, rilanciata da ONG e testate straniere. La diffusione del filmato era illegale non solo per il segreto militare, ma per la manipolazione di materiale sotto indagine: un doppio reato, presentato come atto di eroismo.
Il giornale omette questo dato, trasformando la legalità in censura e la violazione in atto di coraggio. Così la trasparenza diventa colpa, e la procedura giudiziaria un simbolo di repressione.
Damiano Rizzi, nel suo reportage dal campo profughi di Aida, scrive di «bambini che crescono con il suono dei droni», di un luogo dove «ogni giorno vedono soldati armati davanti a casa» e di «una generazione che non conosce altro che paura». L’immagine è potente, ma selettiva.
Non una riga sui tunnel sotto le abitazioni, sull’uso dei minori da parte di Hamas, sulla presenza di milizie armate nei campi. Non una parola sull’educazione all’odio o sull’addestramento dei ragazzi da parte delle brigate.
Il risultato è una narrazione unidirezionale, in cui la sofferenza diventa argomento e la realtà sparisce. «Il campo dei bambini con vista sull’inferno» è un titolo perfetto: basta la metafora, la realtà è superflua. È il marketing del dolore, applicato al giornalismo.
Nel terzo articolo, Massimo Cacciari conclude il trittico con una diagnosi metafisica: Israele come “Impero”, la Palestina come “vittima sacra”, l’Occidente come “complice silente”. Scrive che «Netanyahu pretende l’annientamento della Palestina in quanto entità politica» e che «la guerra permanente è ormai il vero strumento di sopravvivenza del potere».
Nessun riferimento a Hamas, ai 7 ottobre, o al contesto di una guerra scatenata da un massacro. L’analisi sconfina nella teologia: la realtà si dissolve nel simbolo. Il conflitto diventa colpa originaria, Israele l’incarnazione del dominio.
Messi insieme, i tre articoli raccontano lo stesso copione: Israele è colpevole di esistere.
La cronaca di Magrì, la pietà selettiva di Rizzi e la condanna metafisica di Cacciari formano un’unica narrazione in cui Gaza è redenzione e Israele peccato. Il giornale non osserva, ma predica. Non spiega la realtà, ma la sostituisce con un racconto morale dove ogni dettaglio serve a confermare l’accusa.
Il problema non è la critica. È la sparizione del conflitto vero: quello iniziato il 7 ottobre, con l’attacco di Hamas e il massacro di civili israeliani. Quel 7 ottobre non è stato un episodio isolato, ma l’ultimo volto del grande rifiuto arabo: la negazione sistematica, da decenni, del diritto stesso di Israele a esistere, anche entro i suoi confini più minuscoli. Dalla guerra del ’48 agli accordi rifiutati, fino al terrorismo di Hamas, il filo conduttore è sempre lo stesso: non l’occupazione, ma l’esistenza di Israele come scandalo politico e religioso. Altro che impero: è il più piccolo dei Paesi, circondato da chi ne nega il nome.
Da quella data, parte della stampa ha smesso di raccontare i fatti e ha cominciato a costruire un vangelo politico, dove ogni immagine palestinese serve a espiare un senso di colpa occidentale.
Ma la cronaca non è teologia. E quando la sofferenza diventa strumento, l’informazione smette di essere libertà e diventa propaganda.
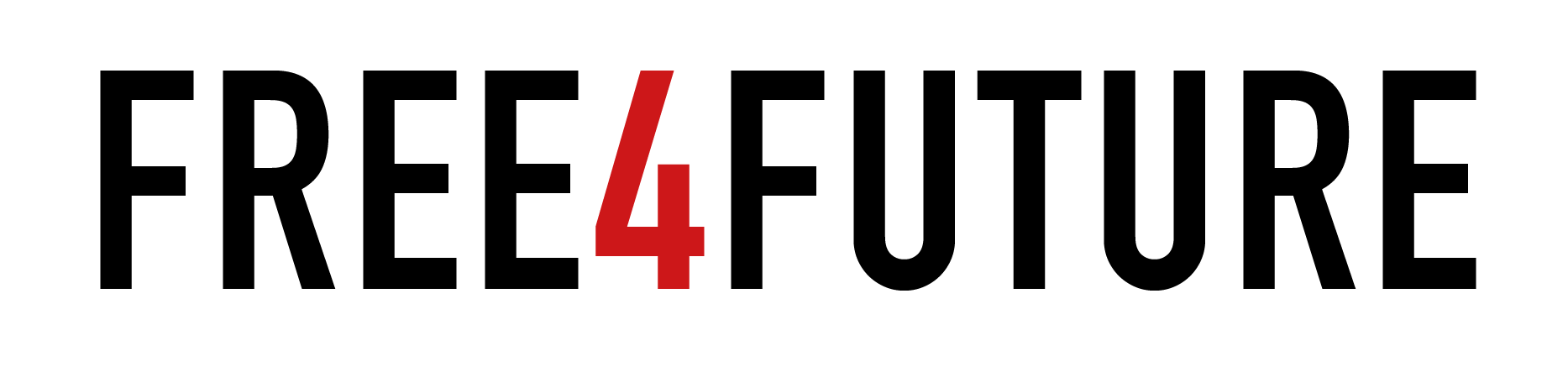





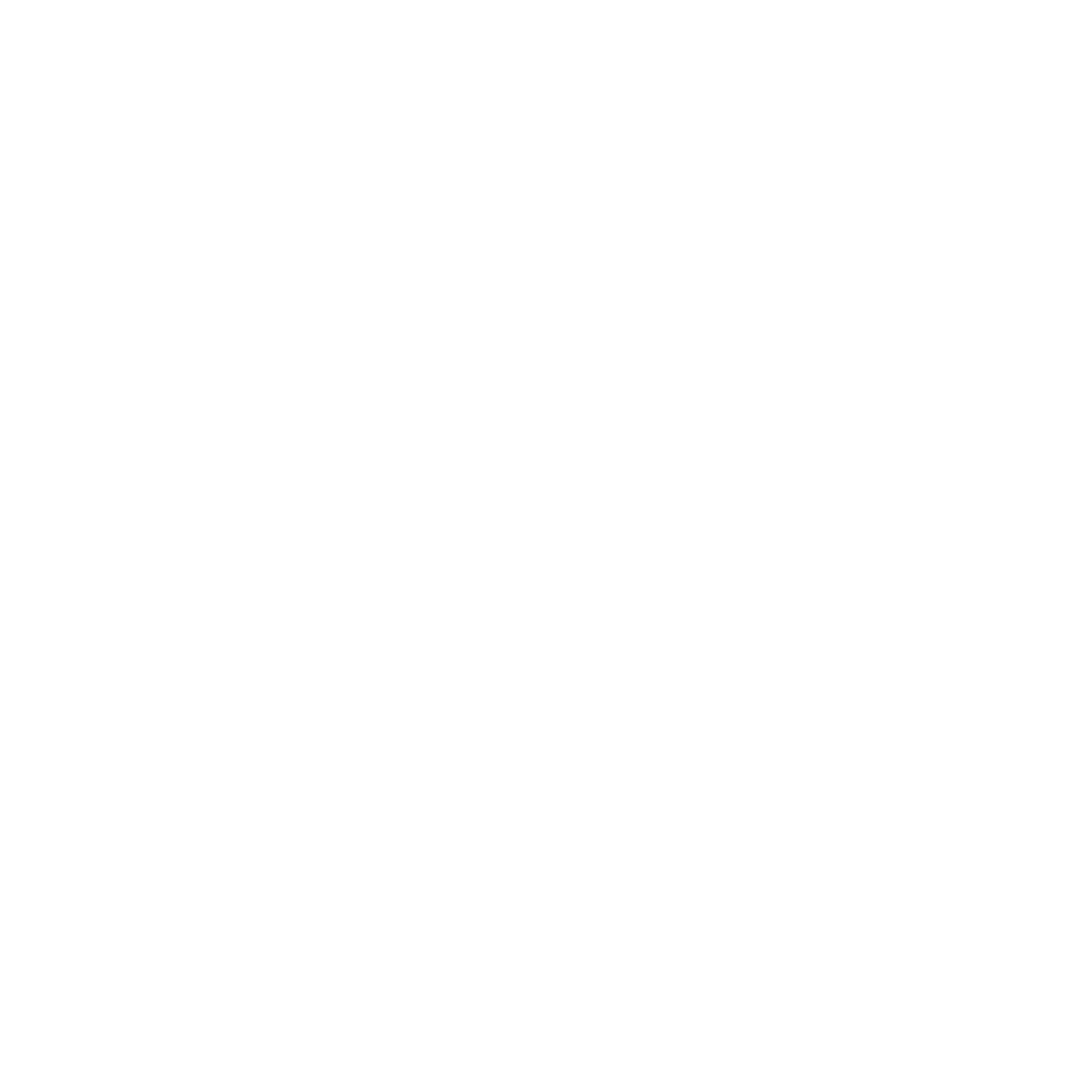
Add comment