Un allarme contro la pace
C’è una fame che fa rumore, ma che con il cibo ha poco a che fare. E poi c’è una carestia che non esiste, ma che riempie le prime pagine dei giornali. A Gaza, ogni camion che entra non porta solo farina: porta una narrazione. Una guerra, anche questa, combattuta con gli aiuti umanitari. E ogni sacco di riso si trasforma in un’accusa: non contro la fame, ma contro Israele.
Parliamo di oltre 300.000 tonnellate di aiuti. Ventiduemila camion, per una popolazione di poco più di due milioni di persone. Se fosse un ristorante – ha scritto Amjad Taha – si servirebbero quattro pasti completi al giorno per sei mesi. Ma la contabilità qui non interessa: interessa il frame. “Genocidio per fame” suona meglio. Fa indignare. Fa cliccare.
Intanto, nel mondo reale, c’è chi muore davvero di fame: in Sudan, in Somalia, nel Sahel. Ma lì non ci sono telecamere. E neppure titoli.
Il 24 maggio, invece, l’Italia si sveglia così.
Su Repubblica, Anna Lombardi apre con “Aiuti con il contagocce e civili allo stremo”.
Il Manifesto parla di Gaza “affamata e umiliata”.
Avvenire rilancia: “C’è cibo solo per un bimbo su tre”.
Domani evoca i peggiori scenari: “Bambini e anziani iniziano a morire di fame”.
La Stampa mette al centro la “disperazione”.
Il Fatto Quotidiano affida il microfono a un portavoce di Al Jazeera: “Fermate il folle piano di Bibi”.
Funziona così. La parola “fame” non ha bisogno di spiegazioni. È immediata, universale. Non richiede fonti né verifiche. Ma a Gaza – questa è la parte che si evita di dire – la fame è soprattutto un racconto. Un racconto funzionale. Che serve a trasformare un’emergenza in leva politica.
Perché a differenza del Tigray o del Niger, Gaza ha un’arma in più: l’ecosistema mediatico. E ha Hamas, che ha capito una cosa semplice e terribile: l’indignazione dell’Occidente è più potente di qualsiasi razzo. Basta saperla coltivare.
E infatti la coltivano bene. Non servono grandi strategie. Bastano immagini forti, parole giuste, volti consumati. E il risultato arriva: aiuti, fondi, pressioni diplomatiche. Tutto il resto – compreso chi gestisce davvero quegli aiuti – viene messo tra parentesi.
Perché nessuno chiede chi li distribuisce. Nessuno indaga chi li intercetta. Nessuno si domanda dove finiscono.
E così, mentre le organizzazioni si dichiarano “neutrali”, i tunnel si riempiono, i depositi si blindano, e la narrazione fa il suo corso. Si parla di pane e farina, ma non si nomina mai chi controlla i magazzini. Chi sequestra, raziona, usa.
È sempre lo stesso schema: più si grida alla fame, più si aprono corridoi, più si inviano aiuti, più Hamas si rafforza.
Non è una distorsione. È il piano.
Una fame disegnata per alimentare la guerra, non per fermarla.
Chi grida all’emergenza senza chiedersi chi la gestisce, chi invoca la tregua ma rifiuta di vedere chi la sabota, chi parla di genocidio e si dimentica dei carcerieri, non aiuta la pace. La posticipa.
La fame, a Gaza, è diventata linguaggio. Un codice.
E in nome dell’umanitarismo, tutto questo non ferma la guerra: la fa continuare.
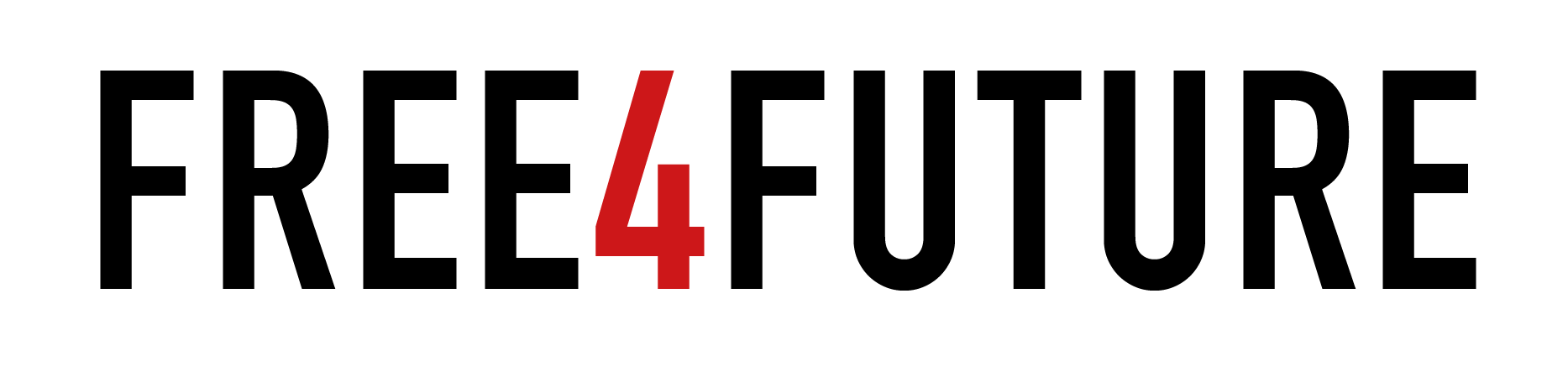





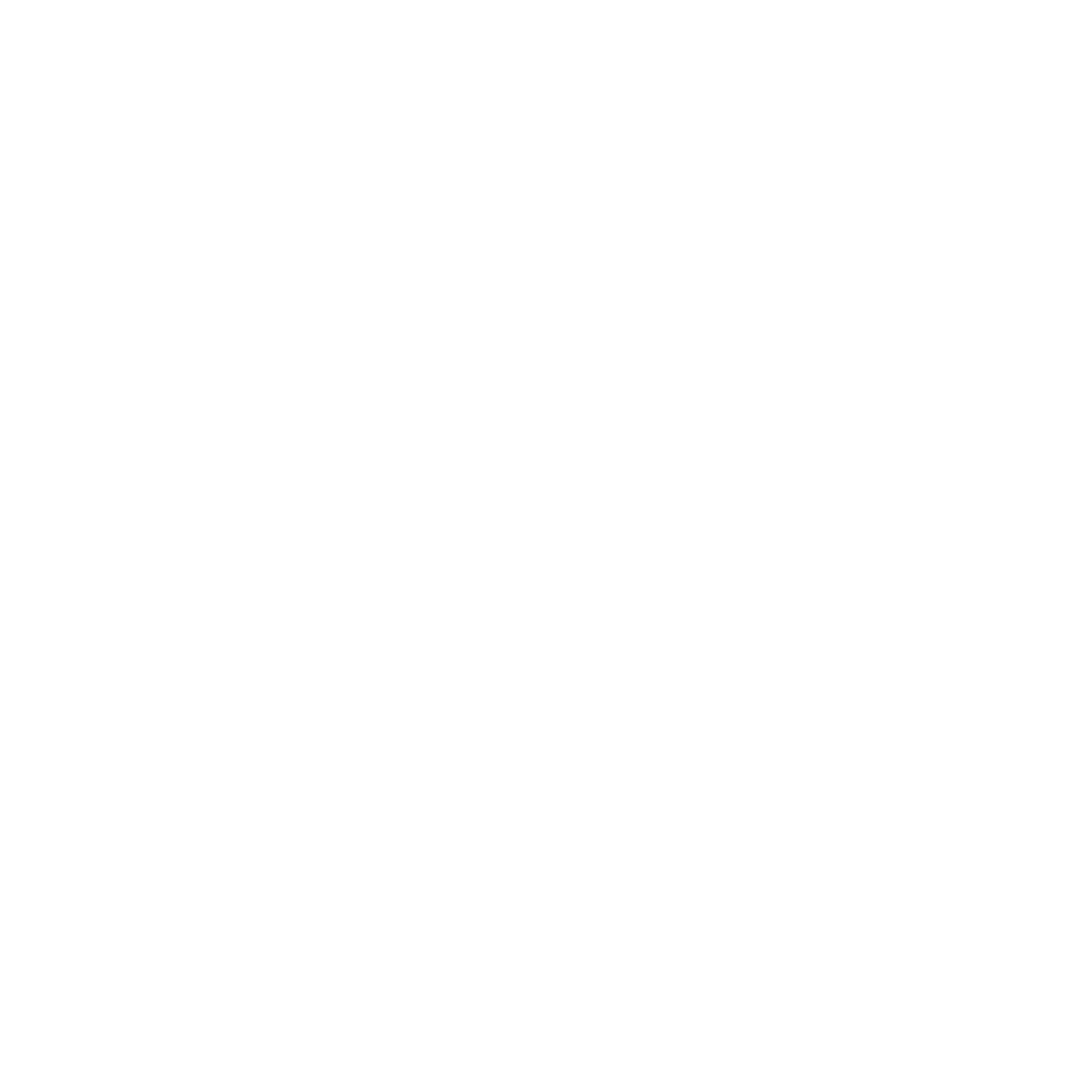
Add comment